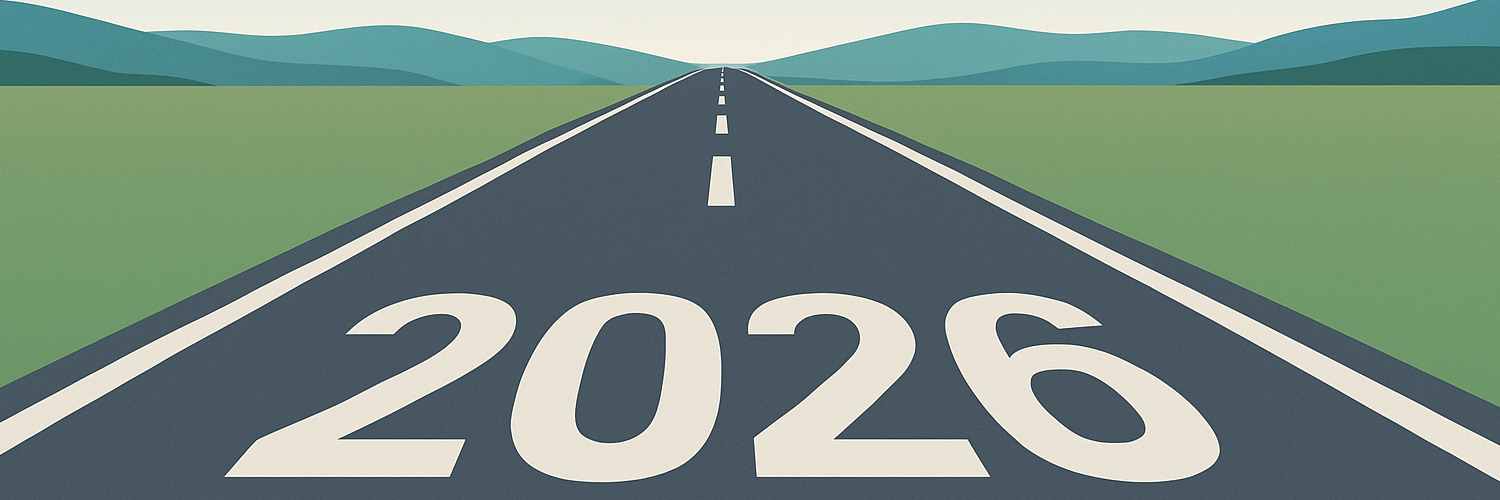Il 2026 incombe, ma non tutto è perduto. Il Governo e la Commissione Europea stanno lavorando a due strumenti in grado di offrire un vero “piano B” per i progetti del PNRR che non arriveranno in tempo al traguardo: il trasferimento sui fondi di coesione e le facility finanziarie. Due soluzioni diverse, ma complementari, pensate per non disperdere risorse e garantire comunque la realizzazione degli interventi.
1. Trasferimento sui fondi di coesione: guadagnare tre anni
Il primo strumento è relativamente semplice: spostare i progetti più in ritardo dal PNRR ai fondi di coesione europei 2021-2027 (FESR e FSE+) e al Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nazionale.
Questi programmi hanno una scadenza più lunga, fino al 2029, e consentono quindi di guadagnare tre anni di tempo.
Si tratta di una soluzione logica per gli interventi infrastrutturali che hanno già un solido disegno progettuale ma tempi tecnici non compatibili con il 2026.
Esempi concreti:
-
Asili nido e scuole dell’infanzia: la misura più in difficoltà del PNRR, ma anche una delle più strategiche per l’Italia. Trasferendola nei programmi di coesione, le Regioni e i Comuni avrebbero più tempo per completare i cantieri e rafforzare i servizi per l’infanzia.
-
Rigenerazione urbana: molti progetti comunali, spesso di piccola scala ma diffusi sul territorio, rischiano di restare indietro. Con i fondi di coesione possono essere riallocati, evitando di lasciare incompiute opere locali importanti.
La chiave sarà la capacità di coordinare il trasferimento: riprogrammare le risorse dei programmi operativi regionali e nazionali, coinvolgere le autorità locali, assicurare che il passaggio non crei vuoti finanziari.
2. Le facility: congelare oggi per spendere domani
Il secondo salvagente è più innovativo e ha un impatto potenzialmente dirompente: le facility finanziarie.
Si tratta di veicoli ad hoc che permettono di impegnare formalmente le risorse PNRR entro il 2026, rispettando così la scadenza europea, ma di spenderle fino al 2029.
Il meccanismo si fonda sul Regolamento (UE) 2021/241: un intervento attuato tramite strumenti finanziari è considerato completato al 100% quando tutte le risorse sono state attribuite ai beneficiari tramite impegni giuridicamente vincolanti. In altre parole, basta che entro il 2026 siano firmati i contratti: i pagamenti e la realizzazione materiale possono slittare di tre anni.
L’Italia e le prime facility
Il nostro Paese ha già sperimentato questo strumento con circa 8 miliardi di euro, ad esempio per i fondi di garanzia e per il sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. Ma ora l’obiettivo è più ambizioso: creare una facility per ogni Ministero in ritardo, così che ciascuno possa mettere al sicuro i propri progetti critici.
Esempi concreti in arrivo
-
Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica (MASE): una facility da circa 4 miliardi affidata al GSE per congelare interventi su comunità energetiche rinnovabili, agrivoltaico, biometano e idrogeno verde. Progetti già avviati, ma che hanno bisogno di tempi più lunghi per iter autorizzativi e connessioni alla rete.
-
Ministero dell’Università: il target dei 60.000 posti letto per studenti sarebbe irraggiungibile entro il 2026, ma con la facility si punta a confermare tutte le domande ricevute, spalmando la costruzione degli studentati fino al 2029.
-
Sanità: si valuta l’uso di una facility per alcuni progetti di Case e Ospedali di Comunità, particolarmente complessi sul piano edilizio e organizzativo.
Opportunità e rischi
Le facility non sono solo un meccanismo di salvataggio: rappresentano anche un’opportunità per integrare PNRR e politiche settoriali, offrendo agli investimenti pubblici un orizzonte più lungo.
Ma non mancano le criticità:
-
occorre il via libera della Commissione Europea;
-
è indispensabile firmare contratti vincolanti entro il 2026, richiedendo una forte capacità amministrativa;
-
bisogna evitare che i progetti restino “congelati” troppo a lungo, senza tradursi in benefici concreti per i cittadini.
Una seconda vita per il PNRR
Combinando i due strumenti – trasferimento ai fondi di coesione e facility – il PNRR può guadagnare una seconda vita fino al 2029.
Non si tratta di una proroga ufficiale, ma di un uso intelligente delle regole europee e dei diversi fondi disponibili.
Il messaggio è chiaro: nonostante i ritardi, i progetti non devono essere abbandonati. Con scelte rapide e una gestione efficace, l’Italia può trasformare i “salvataggi” in occasioni di sviluppo più stabili, capaci di lasciare un’eredità concreta oltre il 2026.